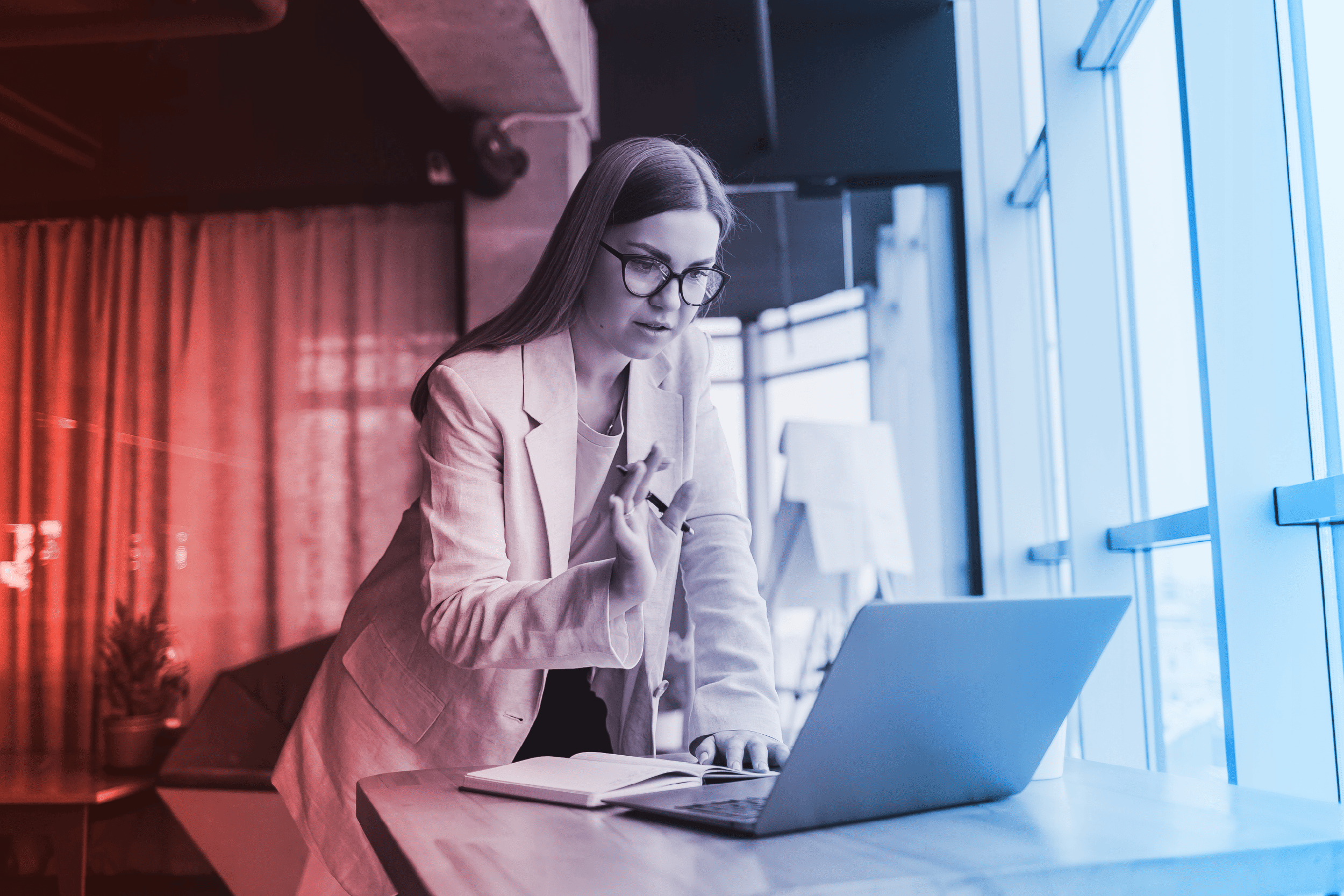
Lo specchio invisibile: come l’organizzazione costruisce (o distrugge) l’identità professionale
Le organizzazioni non gestiscono solo attività, ruoli e performance. Gestiscono, molto più di quanto credano, le identità professionali delle persone che ci lavorano dentro. Non in modo esplicito, non con policy o processi, ma attraverso una sequenza continua di micro-segnali: chi viene ascoltato, chi viene coinvolto, chi viene corretto, chi viene promosso, chi viene lasciato in silenzio. Nel tempo questi segnali costruiscono una narrazione implicita su “chi sei” dentro quell’organizzazione. E quella narrazione finisce per diventare reale.
In psicologia questo meccanismo è noto come Looking-GlassSelf: noi costruiamo l’idea che abbiamo di noi stessi osservando come crediamo che gli altri ci vedano. Non serve che il giudizio sia esplicito. Basta che sia coerente. Basta che si ripeta. Se una persona viene trattata come “non ancora pronta”, comincerà a comportarsi come se non lo fosse. Se viene trattata come“non strategica”, smetterà di pensare in modo strategico. Se viene trattata come “affidabile ma esecutiva”, smetterà di proporsi come qualcosa di diverso.Non perché non potrebbe, ma perché il contesto le ha insegnato che quella versione di sé non è quella richiesta, non è quella accolta, non è quella che ha spazio.
Questo è uno dei punti più sottovalutati nella gestione delle persone: i sistemi non si limitano a selezionare il talento, lo modellano. Lo fanno lentamente, senza rumore, senza conflitto. E spesso lo fanno in direzione regressiva. Non abbassando la competenza, ma restringendo il perimetro psicologico in cui quella competenza viene esercitata. È così che nascono le organizzazioni piene di persone formalmente qualificate, ma interiormente ridotte. Persone che potrebbero dare di più, ma hanno smesso di pensare che sia legittimo farlo.
Dal punto di vista manageriale questo è un tema centrale, perché impatta direttamente su tre variabili critiche: iniziativa, responsabilità e qualità del pensiero. Se le persone non si sentono viste come soggetti pensanti, smettono di pensare. Se non si sentono viste come responsabili, smettono di prendersi responsabilità. Se non si sentono viste come portatrici di valore, smettono di portarlo. Non per mancanza di motivazione, ma per adattamento.
La leadership, in questo senso, è molto meno una questione di stile e molto più una questione di specchio. Ogni manager è uno specchio in cui gli altri cercano di capire chi sono in quel contesto. Uno specchio può amplificare, può chiarire, può distorcere, può ridurre. Ma non è mai neutro. Ogni feedback, ogni delega, ogni non-detto comunica qualcosa sull’identità dell’altro. E quell’identità, col tempo, si stabilizza.
Le organizzazioni più performanti non sono quelle che spingono di più, ma quelle che allargano di più. Allargano lo spazio in cui le persone si sentono legittimate a crescere, a osare, a sbagliare, a pensare in modo più grande del loro ruolo attuale. Non perché “ci credono”, ma perché strutturano i loro sistemi — di valutazione, di sviluppo, di riconoscimento —in modo coerente con questa intenzione. Rendono visibile il potenziale prima che sia pienamente espresso. Trattano le persone non solo per quello che sono oggi, ma per quello che potrebbero diventare.
Questo non è idealismo. È progettazione organizzativa. È capire che le persone non sono entità statiche che l’azienda si limita a misurare, ma sistemi adattivi che rispondono al contesto. E che quindi il contesto è parte integrante della performance.
Alla fine, le persone non lasciano le aziende solo perché non crescono. Le lasciano perché in quell’ambiente imparano a diventare più piccole. E nessun talento, per quanto forte, regge a lungo in uno spazio che lo riduce.
Se un’organizzazione vuole davvero parlare di sviluppo, deve prima farsi una domanda molto semplice e molto scomoda: che tipo di persone sto rendendo possibile qui dentro? Perché la risposta a quella domanda è il vero output della leadership. Tutto il resto sono KPI.

.png)

