
Effetto Flynn: il QI cresce ancora o stiamo diventando più veloci a filmare che a pensare?
C’è stato un tempo in cui ogni generazione sembrava diventare più intelligente della precedente. Un tempo in cui il Quoziente Intellettivo (QI) aumentava costantemente, come un indice di borsa. Questo fenomeno, noto come Effetto Flynn, ha segnato il Novecento con un incremento medio di 3 punti di QI ogni decennio nei paesi industrializzati. Un’impennata attribuita a migliori condizioni igienico-sanitarie, accesso all’istruzione, alimentazione, stimoli cognitivi sempre più vari.
Oggi? L'effetto Flynn è in recessione.
Negli ultimi vent’anni, molti paesi occidentali stanno registrando un’inversione di tendenza. Secondo uno studio dell’Università di Oslo (Bratsberg & Rogeberg, 2018), i punteggi medi dei test di QI in Norvegia sono in calo dal 1995. Dati simili arrivano da Danimarca, Francia, Olanda, Germania, Regno Unito e Stati Uniti. Anche in Italia, seppur con meno evidenze strutturate, le indagini PISA dell’OCSE suggeriscono un peggioramento delle competenze cognitive di base tra i giovani.
Alcuni studiosi lo definiscono “reverse Flynn effect”: un declino cognitivo progressivo che non può essere ignorato.
Il cortocircuito digitale: connessi, ma disconnessi
Nel frattempo, è esplosa la rivoluzione digitale. E con lei i social network, lo scroll compulsivo, la frammentazione dell’attenzione. Il cervello umano, progettato per concentrarsi su compiti sequenziali e profondi, è ora sottoposto a un bombardamento continuo di stimoli effimeri.
Uno studio Microsoft del 2021 ha rilevato che l’attenzione media umana è scesa a 8 secondi, meno di quella di un pesce rosso. Ma ridurre il tema dell’intelligenza alla soglia di attenzione sarebbe semplicistico. Il vero rischio è la perdita della capacità riflessiva, la difficoltà nel costruire pensieri articolati, la progressiva atrofia del linguaggio.
Per chi lavora in ambito HR, questo si traduce in candidati che faticano a sostenere un colloquio complesso, a comprendere testi articolati, a esprimere pensieri autonomi al di là dei pattern appresi.
Giovani ed empatia: il disagio non è una questione di attenzione
Spesso si racconta che le nuove generazioni siano più empatiche, inclusive, sensibili. Ma è una narrazione che merita un fact-check. Perché se da un lato esistono giovani lucidi, impegnati e consapevoli, dall’altro assistiamo a un aumento del disagio sociale e relazionale.
Nelle cronache quotidiane italiane si moltiplicano episodi di violenza gratuita tra adolescenti, atti filmati e condivisi invece che fermati. Bullismo, mancanza di rispetto per l’autorità, disinteresse per la relazione autentica. Non è solo una questione di educazione, ma di impoverimento emotivo e valoriale.
Uno studio dell’Università del Michigan, basato su oltre 14.000 studenti, ha rilevato che l’empatia è calata del 40% dal 2000 ad oggi. Questo non dipende direttamente dall’uso del digitale, ma da un contesto culturale che ha smesso di allenare la fatica, il limite, la convivenza con la frustrazione. E anche questo è un tipo di intelligenza: quella che serve per stare in società, per lavorare in team, per costruire relazioni sane.
Allora, si può invertire la rotta? Sì, ma serve un piano.Anche per noi HR.
Non possiamo limitarci a dire che “i giovani sono meno motivati” o che “non leggono più”. Serve un cambio di sguardo, e un impegno condiviso per ricostruire contesti che stimolino intelligenza, complessità e relazione.
Ecco il piano di allenamento dell’intelligenza per l’epoca digitale
1. Incentivare la lettura profonda: Testi lunghi, ben scritti, densi. Ogni giorno. Non solo newsletter o caption, ma narrazioni e saggi.
2. Scrittura riflessiva: Diario, articoli, report: scrivere aiuta a pensare. Nelle aziende, può diventare uno strumento di formazione continua.
3. Tempo off-screen intenzionale: Disconnettersi per almeno 1 ora al giorno. Rigenera la memoria, la lucidità, la presenza.
4. Conversazioni vere: Favorire il confronto reale, in aula o in azienda, allena all’ascolto e alla coesistenza delle differenze.
5. Allenare il linguaggio: Arricchire il lessico migliora anche il pensiero. Un vocabolario ricco consente una visione più articolata della realtà.
6. Favorire il pensiero critico: Abituare le persone a porsi domande, anche scomode. Nessuna intelligenza cresce nella comfort zone cognitiva.
7. Educare all’empatia reale, non dichiarata: Relazioni intergenerazionali, mentorship, team misti. L’empatia si trasmette, se viene vissuta.
8. Valorizzare l’impegno, non solo la performance: Tornare a dare valore alla fatica, alla costanza, alla crescita. Anche a scuola, anche in azienda.
L’Effetto Flynn ci ha abituati all’idea che ogni generazione sarebbe stata più brillante della precedente. Ma il presente ci chiede di guardare in faccia un paradosso: abbiamo più stimoli, ma meno profondità. Più connessioni, ma meno comprensione. Più strumenti, ma meno saggezza.
Per chi lavora nelle risorse umane, la sfida è duplice: accogliere i segnali di cambiamento senza giudizio, ma anche tenere il punto su ciò che serve per vivere e lavorare con intelligenza. Non solo QI, ma anche rispetto, linguaggio, cura dell’altro.
Perché se l’intelligenza si misura con un test, la sua assenza si vede nella realtà. E lì non possiamo più permetterci di chiudere gli occhi.
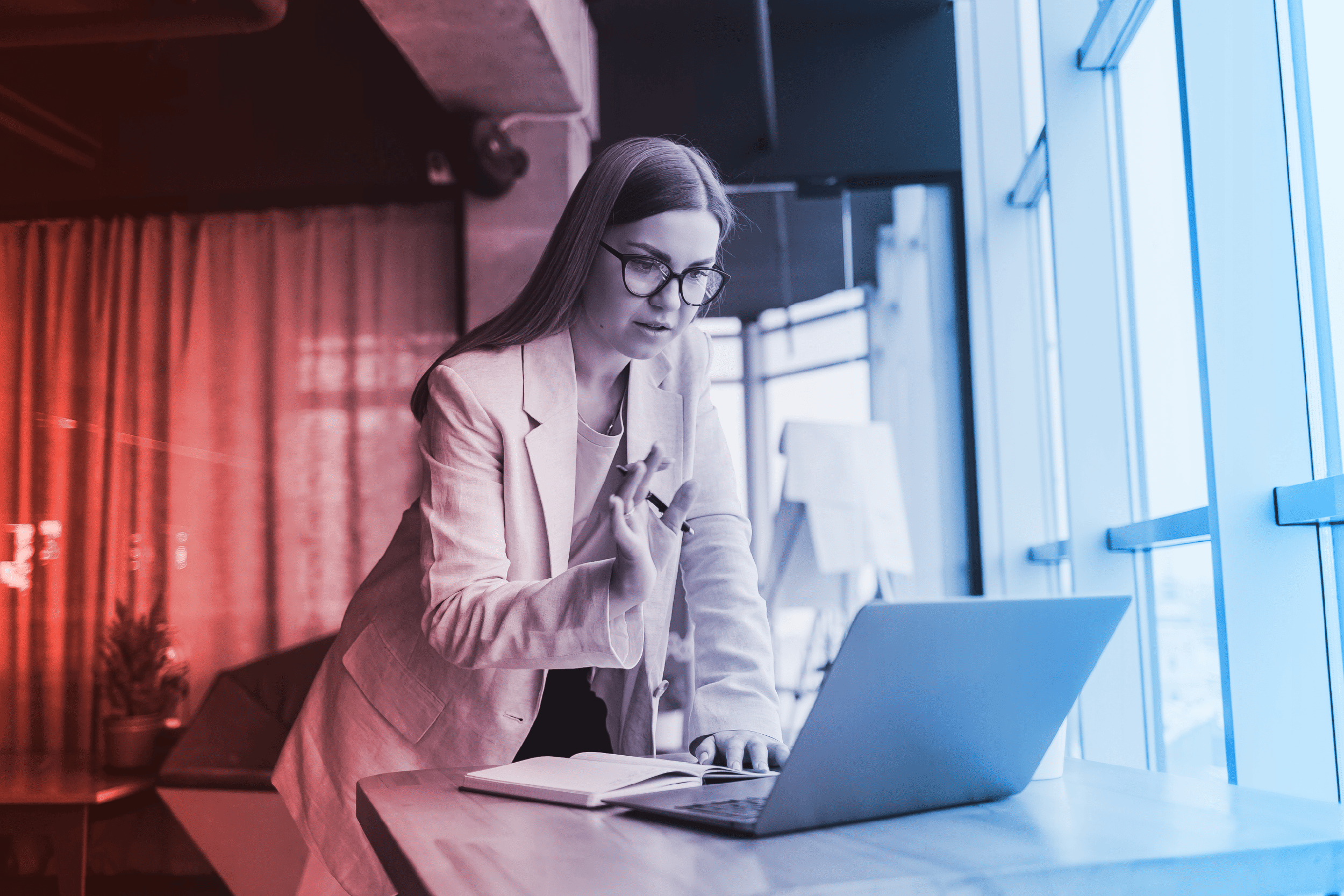

.png)
